L’amore e l’altro mondo nell’immaginario
medievale: un percorso in quattro testi, da Andrea Cappellano a Boccaccio
I. In una calda e luminosa
giornata d’estate un nobile cavaliere, insieme ad altri suoi pari, cavalca per
la selva reale di Francia al seguito del suo signore. La compagnia si ferma a
riposare in un locus amoenus, mentre i cavalli si dilettano al pascolo.
Quando si tratta di ripartire, il nostro cavaliere, attardatosi a rintracciare
il proprio cavallo che si era allontanato, si ritrova solo e si mette alla
ricerca della compagnia. Comincia così per lui una straordinaria avventura, che
lo porta prima ad incontrare una cavalleria di morti e poi a visitare la loro
sede ultraterrena.
Il
corteo incontrato è guidato dal dio Amore ed è composto da donne, suddivise in
tre gruppi. Nel primo gruppo ci sono donne molto belle e ben vestite, che
cavalcano un palafreno lussuosamente bardato e sono accompagnate ciascuna da
due cavalieri che procedono al loro fianco e da un terzo appiedato che guida a
mano il loro cavallo: sono, costoro, quelle "beatissime donne" che in
vita concessero il loro amore agli amanti che ne erano degni, e che perciò ora
ricevono, come ricompensa, tale onore. Le donne del secondo gruppo sono
accompagnate da una gran quantità di servitori, a piedi e a cavallo, ma la
moltitudine e la confusione sono tali che esse, invece di essere adeguatamente
servite, ricevono soltanto impaccio nel cavalcare: si tratta delle donne che in
vita si concessero a tutti senza discrezione, e che perciò ora hanno in cambio
tale condizione disagiata. Nel terzo gruppo ci sono donne mal vestite,
costrette a cavalcare senza sella su cavalli macilenti e zoppicanti, senza
alcun cavaliere che le accompagni e le serva, per di più accecate e soffocate
dalla molta polvere sollevata dal gruppo precedente: sono queste le donne che
in vita "mantennero chiusa la porta dell’amore", rifiutarono di
concedersi anche ai cavalieri che degnamente le avrebbero amate, preferirono la
castità e perciò ora subiscono la giusta punizione.
Anche
nel regno governato dal dio Amore, ove il nobile protagonista giunge al seguito
del corteo, le tre schiere hanno una collocazione corrispondente: di premio o
di punizione, secondo criteri analoghi a quelli riscontrati nella cavalcata. In
una radura ci sono tre zone concentriche: quella più interna (Amoenitas)
è una sorta di paradiso terrestre, e lì, all’ombra di un grande albero e presso
il trono del dio Amore, risiedono felici con i loro cavalieri le donne che
amarono e si lasciarono amare cortesemente; nella zona intermedia (Humiditas),
su prati inondati da acqua gelida, sono collocate le donne di facili costumi;
in quella più esterna (Siccitas), arsa da un sole cocente, si trovano le
donne che si vollero mantenere caste, ora costrette, per maggiore tormento, a
sedere su dolorosi fasci di spine.
Tutto
ciò è raccontato da Andrea Cappellano nel primo libro del De amore (1),
il trattato in cui si dà sistemazione teorica a quella concezione
dell’"amor cortese" (o fin’amor) che, nata in Provenza alla
fine del sec. XI, si sarebbe poi diffusa negli ambienti colti di tutta Europa (2).
La
narrazione di visioni d’oltretomba, di defunti che ricevono premi o punizioni a
seconda del loro comportamento in vita, non è infrequente nel Medioevo: ciò che
qui è notevole è non tanto che il comportamento in questione sia esclusivamente
relativo all’amore (come era da aspettarsi, visto l’argomento oggetto del
trattato di Andrea), quanto il fatto che l’amore sia assolutamente dissociato
dall’idea cristiana di peccato, ed anzi esaltato e premiato nell’oltretomba,
quando praticato in vita secondo i canoni della cortesia (3). Né può sfuggire
che, nella visione testé narrata, la condizione peggiore (direi ‘infernale’,
adottando una categoria che appartiene all’oltretomba cristiano) è riservata
alle donne che praticarono la castità (4), ovvero la virtù per eccellenza
secondo la morale cristiana, mentre una sorta di ‘regno intermedio’ c’è per le
donne che, vere e proprie lussuriose, si concessero indiscriminatamente (5); al
‘paradiso’ hanno accesso le donne che non negarono il loro amore, ma
corrisposero, com’era giusto e doveroso, alla richiesta degli amanti cortesi (6).
La
dottrina, dunque, che ispira la visione di Andrea, è in aperto contrasto con la
dottrina cristiana, anzi si struttura come una vera e propria religione
antitetica a quella cristiana: c’è un’oltretomba, come s’è visto, e c’è un dio,
Amore, che attribuisce premi e castighi secondo un rigoroso contrappasso, che
determina la condizione ultraterrena in relazione al comportamento tenuto in
vita. Ciò appare anche più evidente se si nota che, nella concezione cortese,
l’amore è sì sentito come un sentimento nobile e nobilitante, ma non per questo
è ridotto ad un fatto puramente spirituale, depauperato delle sue componenti
erotico-sensuali: al contrario, tali componenti - apertamente valorizzate nel
trattato di Andrea (7) - costituiscono le fondamenta su cui si innalza la
grande elaborazione culturale dell’amor cortese; e il fatto che l’adulterio ne
sia un canone qualificante (8), dimostra una volta di più, se ce ne fosse
bisogno, che l’amore di cui si tratta è un amore-passione, in forza di ciò
legittimato a realizzarsi al di fuori dei vincoli di interesse e convenienza
connessi con il matrimonio. In altre parole si potrebbe anche dire che la
dottrina in questione, di cui Andrea è il grande divulgatore, intende dare
dignità morale a quella passione amorosa da sempre oggetto della riprovazione
della Chiesa.
Nel
merito, la storia secolare dell’atteggiamento della Chiesa, da Paolo di Tarso a
Tommaso d’Aquino, è sostanzialmente una storia di condanne: la passione
d’amore, che travolge la ragione, è peccaminosa, è il segno dell’imperfezione
umana dopo la Caduta; l’amore carnale, fuori del matrimonio, non si giustifica
in alcun modo, nel matrimonio è tollerato ai fini della procreazione, ma, anche
in questo caso, con le dovute cautele, perché il desiderio è intrinsecamente
malvagio. Basterà ricordare, per tutti, Gerolamo che, nell’Adversus
Jovinianum, bolla così il desiderio troppo intenso del marito: "Adulter
est in suam uxorem amator ardentior... Sapiens vir iudicio debet amare
coniugem, non adfectu... Nihil est foedius quam uxorem amare quasi adulteram."
(9).
Di
tutto ciò Andrea era ben consapevole, se è vero che la ritrattazione del III
libro (De reprobatione amoris) è motivata anche dalla paura di incorrere
in una condanna per eresia. Il "cappellano", da buon chierico, finiva
per negare, in nome della verità di fede, ciò che per due libri aveva esaltato
in nome della verità di ragione: quello stesso amore che era stato celebrato
come fonte di ogni azione virtuosa e degna di lode, viene ora indicato, nel III
libro, come grave offesa a Dio, origine di ogni comportamento delittuoso, causa
di dannazione eterna. Ma evidentemente quella ritrattazione, così poco
convincente per noi, nemmeno convinse l’autorità ecclesiastica: le "due
verità" non potevano coesistere, e la condanna (che intendeva colpire
proprio la tesi della "doppia verità" sostenuta dagli averroisti
latini) si abbatté sul libro di Andrea il 7 marzo del 1277, per opera del
vescovo di Parigi, Stephen Tempier (10).
Del
resto, quella condanna, che arrivava circa un secolo dopo la pubblicazione del
libro, non era che l’ultimo anello di una catena che aveva finito per
strangolare, insieme all’amor cortese, la possibilità stessa di fondare una
morale e un pensiero alternativi a quelli imposti dalla ortodossia cattolica.
E’
una storia che, per un verso, rimanda a quella delle dispute teologiche che,
nel corso dei secoli XII e XIII, videro contrapporsi scuole di pensiero di
ascendenza aristotelica e platonica; per altro verso, si intreccia con la
vicenda della persecuzione delle eresie, che ebbe come momento culminante la
crociata contro gli Albigesi voluta da papa Innocenzo III nel 1208.
Per
quanto riguarda il primo aspetto, basterà ricordare che certo ‘naturalismo’ di
ispirazione platonica (si pensi, in particolare, ai poeti e filosofi della
scuola di Chartres, attivi nella prima metà del XII secolo) proprio in quanto
metteva l’accento sulle potenzialità della Natura, vicaria di Dio, finiva anche
per valorizzare l’intrinseca bontà dell’amore terreno fra l’uomo e la donna. Il
prevalere dell’aristotelismo, soprattutto per opera di Tommaso d’Aquino nella
seconda metà del XIII secolo, sia sul piano teologico ristabilì le distanze fra
il cielo e la terra, sia sul piano morale relegò definitivamente nel territorio
del peccato l’etica profana dell’amore cortese (11).
Ma
quell’etica dovette subire il contraccolpo anche sul fronte della guerra che la
Chiesa di Roma combatté e vinse contro le eresie. Quale che fosse la relazione
fra il catarismo, particolarmente vigoroso nel sud della Francia, e la grande
cultura cortese fiorita pressoché contemporaneamente negli stessi luoghi (12),
non c’è dubbio che la crociata contro gli Albigesi non si limitò ad estirpare
la mala pianta dell’eresia, ma determinò anche in modo irreversibile il
tramonto di quella civiltà. In particolare, non poteva avere cittadinanza
all’interno della comunità cristiana la concezione dell’amore che celebrava
apertamente una passione tutta terrena e addirittura idealizzava l’adulterio:
fu perseguita come una peste, come il frutto avvelenato di quella haeretica
pravitas che, in spregio del matrimonio, sembrava aver rovesciato il detto
paolino (melius est nubere quam uri) nel suo contrario (melius est
uri quam nubere).
II. Ma in Italia, nel 1277,
la peste si era già diffusa. Non solo perché a quella data il De amore
risulta già conosciuto (13), ma proprio perché la lirica siciliana dell’età di
Federico II sembra avere importato in Italia quegli ideali di amore cortese,
banditi nelle terre d’origine.
Di
quegli ideali si nutre più di una generazione di poeti, quegli ideali (e quindi
il De amore, che li organizza sistematicamente) costituiscono una
componente fondamentale nella cultura di ogni poeta del sec. XIII, dai
siciliani agli "stilnovisti", da Jacopo da Lentini a Dante (14).
Dante
ha letto gli autori provenzali, conosce il trattato di Andrea, padroneggia
quelle problematiche, come era pressoché indispensabile per chiunque volesse
trattare d’amore. Ma è per lui un bagaglio sempre più pesante, in quanto quella
cultura, con quel sistema di valori, in particolare con quella concezione laica
dell’amore, non può non scontrarsi, nella sua coscienza, con i dettami della
morale cristiana. Di tale scontro - e della continua ricerca di una superiore
conciliazione - è testimonianza esemplare il percorso poetico che conduce dalla
Vita Nova alla Commedia .
Ed
è interessante notare come proprio l’episodio di Francesca, nel V dell’Inferno,
sia segno di un rapporto intensamente, e drammaticamente, vissuto dall’autore
con i modelli proposti dalla cultura cortese. Un rapporto mai dimenticato, ma
ormai inaccettabile alla luce di una concezione che ha tolto all’amore ogni
connotazione mondana per collocarlo in una dimensione autenticamente religiosa
(di una religione, cioè, in cui è Cristo abate del collegio, e non
Amore) e attribuirgli la capacità di innalzare l’anima fino alla contemplazione
di Dio.
Nel
V dell’Inferno ci troviamo di fronte ad una visione dell’oltretomba che, fatte
le debite proporzioni, non può non rievocare quella immaginata da Andrea nel I
libro del De amore: in entrambi i casi è la passione d’amore l’elemento
rispetto al quale si è giudicati e "mandati" per l’eternità.
Ovviamente, mentre in Andrea - dato l’argomento da lui trattato - questo è
l’unico motivo preso in considerazione, per Dante quello segnato dalla passione
d’amore non è che uno fra i tanti caratteri che individuano il viaggio terreno
dell’uomo e, di conseguenza, il suo eterno destino; e mentre la visione di
Andrea è soltanto un momento didascalico all’interno di un trattato teorico, la
Francesca di Dante, nel poema cui han posto mano e cielo e terra, non è
che una figura fra le tante che compongono il quadro, grandioso e totale, della
condizione umana.
Ma
se si restringe lo sguardo al motivo oggetto di riflessione in entrambi gli
episodi (la passione d'amore, appunto, ovvero il modo in cui tale passione è
stata concepita e praticata nella vita terrena) non pare improprio il
confronto; e non solo perché, come è già stato rilevato (15), è comune l’idea
del viaggiatore, perdutosi nella selva, cui è concesso di apprendere la
condizione nell’aldilà perché possa riferirne ad ammaestramento dei viventi; o
perché tale condizione appare regolata, analogamente, dalla legge del
contrappasso, o per altre similitudini che vi si vogliano riscontrare; quanto perché
il confronto ci consente di misurare appieno la distanza che separa le due
concezioni, una distanza che conduce addirittura ad un rovesciamento di
prospettiva, ad una inconciliabile opposizione.
L’amore
esaltato da Andrea, l’amore proprio di chi ha cuore gentile, l’amore nobile e
nobilitante, e perciò santificato nel suo oltretomba, è diventato nella Commedia
peccato di lussuria, proprio di coloro che la ragione sommettono al talento,
un peccato che conduce alla dannazione eterna. Analogamente, alla condizione
beata delle donne cui è reso ogni onore e servizio nella visione di Andrea,
corrisponde nella Commedia la condizione di Francesca, travolta per
sempre dalla bufera infernale. E si badi: il comportamento per cui Francesca è
punita non differisce da quello che nel De amore si raccomanda come
esemplare; non differisce, perché Francesca non ha concesso il suo amore
indiscriminatamente, ma, lei gentile, ha corrisposto all’amore di un uomo
gentile, com’era doveroso; né è l’adulterio a fare la differenza, visto che la
condizione extra-coniugale degli amanti è indicata espressamente nel trattato
di Andrea come qualificante l’autenticità dell’amore. Queste cose Francesca le
sa: perciò dichiara a voce alta la sua colpa, che lei continua a non sentire
come una colpa.
E
ovviamente, ancor prima di lei, le sa l’autore della Commedia, che qui
si trova non solo a regolare i conti con la grande tradizione della cultura
cortese, ma anche a combattere con i fantasmi della propria giovinezza: non
altrimenti si spiega la forte intensità emotiva che pervade l’intero episodio,
e coinvolge, come mai in seguito, il visitatore dell’oltretomba fino al punto
estremo di non sopportazione (Io venni meno sì com’io morisse. / E caddi
come corpo morto cade).
Le
parole con cui Francesca si giustifica - e sono quelle racchiuse dalle terzine
famose, introdotte dalla triplice anafora Amor ch(e)..., Amor ch(e)...,
Amor... - sono parole care alle orecchie di Dante: con quelle parole sono
professati i principi dell’amor cortese, quasi nei termini di una traduzione
delle regole enunciate da Andrea nel De amore (16). Di più: il primo
verso (Amor ch’al cor gentil ratto s’apprende) rimanda ad un autore
amatissimo (il padre / mio e de gli altri miei miglior che mai / rime d’amor
usar dolci e leggiadre), quel Guinizzelli, maestro indimenticabile, che
aveva cantato Al cor gentil rempaira sempre amore; un insegnamento ben
recepito dall’allievo, che l’aveva ripreso in un sonetto della Vita Nova
(Amore e ’l cor gentil sono una cosa, / sì come il saggio in suo dittare
pone).
Ma
anche il "saggio" aveva sbagliato: non aveva visto il pericolo
implicito nell’affermazione di quella identità (tra amore e cor gentile), non
era riuscito a liberarsi completamente della zavorra che tratteneva a terra
quell’idea dell’amore. Beatrice ha indicato un’altra strada: l’amore virtuoso
si determina, sì, fra persone fisicamente concrete, ma è capace di staccarsi
dalla materialità corporea, si risolve in un processo di purificazione
interiore, diventa elevazione al cielo. Fuori di questa strada c’è la
prevaricazione del "talento" sulla "ragione", e non varranno
nobili intenzioni e nobile sentire a salvare Francesca dalla dannazione eterna.
Per lei, e per la sua umana debolezza, potrà esserci "pietà", ma nel
buio del cerchio in cui è relegata sarà per sempre travolta dal turbine, così
come in vita si lasciò travolgere dalla lussuria.
III. Chi non patisce un
siffatto dramma interiore, ma ha invece solide certezze, è Jacopo Passavanti,
il frate domenicano vissuto nelle prima metà del sec. XIV, autore di un
trattato (lo Specchio di vera penitenza) in cui sono raccolte le
prediche da lui stesso tenute nella quaresima del 1354 (17). Servendosi di
racconti esemplari (exempla) quanto mai vividi, Passavanti intende
ammonire i fedeli ad astenersi dal peccato e a fare penitenza, se non vogliono
incorrere, dopo la morte, nei rigori della giustizia divina. Fra questi, l’exemplum
del carbonaio di Niversa è certamente uno dei più famosi (18); ed è anche
interessante per il nostro discorso, perché, essendo ancora una volta la
passione d’amore il peccato oggetto di punizione nell’aldilà, richiama
inevitabilmente alla memoria le precedenti visioni di Dante e di Andrea
Cappellano.
Vi
si racconta di come un carbonaio assista nottetempo, mentre veglia presso la
fossa accesa dei carboni, alla visione terrificante di una "caccia
tragica": uno cavaliere in su uno cavallo nero correndo, con uno
coltello ignudo in mano insegue una femmina scapigliata e gnuda; la
raggiunge e, senza pietà per le sue grida disperate, la afferra per li
svolazzanti capelli, la trapassa in mezzo al petto con il coltello e la
getta nella fossa dei carboni ardenti; quindi la riprende tutta focosa et
arsa, la carica sul suo cavallo e se ne torna al galoppo per la via
dond’ era venuto. La visione si presenta identica per tre notti, finché il
carbonaio ne parla al conte di Niversa, il quale assiste di persona alla
visione e quindi, per quanto spaventato, osa chiederne ragione al feroce
cavaliere. Costui gli rivela che tale atroce condizione, di cacciatore e preda,
spetta a lui e alla donna che fu la sua amante (entrambi, in vita, nobili alla
corte del conte), giacché noi, prendendo piacere di disonesto amore l’uno
dell’altro, ci conducemmo a consentimento di peccato a tal punto che lei,
per essere più libera, uccise il proprio marito; pertanto ora, per la legge del
contrappasso che regola la giustizia divina, lei, in quanto uccise il marito,
subisce ogni notte l’uccisione per mano dell’amante; e così come arse d’amore
per lui, ora è gettata da lui ad ardere nei carboni infuocati; infine, così
come in vita vide il suo amante con desiderio e piacere, ora lo vede ogni notte
con odio e terrore. Siccome poi, chiarisce il cavaliere, loro due peccatori si
pentirono in punto di morte, la misericordia di Dio mutò la pena eterna
dello ’nferno in pena temporale di purgatorio; pertanto egli sollecita preghiere,
elemosine e messe affinché le loro sofferenze siano alleviate.
Questo,
in sintesi, l’exemplum narrato da Passavanti. E non si può non avvertire
che, per quanto la pena descritta sia di purgatorio e non di inferno,
temporanea e non eterna, purtuttavia la stessa è così orribile che al confronto
impallidisce la pena di Paolo e Francesca (i quali, nel loro inferno, non si
vedono con odio e terrore, ma insieme vanno ancora legati da un amore
che sembra sfidare la stessa legge divina che li ha dannati). E’ evidente che
per fra’ Jacopo la passione d’amore non ammette scusanti, non porta con sé
alcun segno di nobiltà, è ormai soltanto esecrabile concupiscenza della carne:
la morale cristiana ha fatto valere appieno i suoi principi, senza più dubbi e
senza perplessità, quei dubbi e quelle perplessità che avevano reso così
dolorosamente lacerante l’incontro di Dante con Francesca. E si badi: non è
tanto l’uxoricidio, quanto il disonesto amore a determinare per i due (e
per la donna in particolare) una punizione così terribile; l’uxoricidio è
tuttalpiù un aggravante, certo una conseguenza, come ogni altra nefandezza, di
un peccato che comporta offuscamento della ragione (di un peccato proprio di
coloro che, appunto, la ragione sommettono al talento).
Dunque,
il disonesto amore: e "disonesto" perché adulterino. Niente di
più distante dalle teorizzazioni di Andrea Cappellano. Là l’adulterio, lungi
dall’essere deplorato, era raccomandato. Né si può pensare che in Passavanti la
"disonestà" sia associata alla mancanza di cortesia dei due
protagonisti; perché è vero che niente si dice sui loro costumi e che il
cavaliere non tenta di giustificare - a differenza di quel che fa Francesca -
con il "cuore gentile" la caduta nel peccato; ma è anche vero che il
loro nobile lignaggio lascia intendere di per sé, in mancanza di indicazioni
contrarie, un mondo di belle cortesie, all’interno del quale, secondo la
dottrina enunciata da Andrea, quell’amore, ancorché carnale e adulterino,
avrebbe avuto pieno titolo per realizzarsi.
L’ombra
nera della notte avvolge la scena, una notte lugubremente rischiarata dal rosso
vivo dei carboni accesi e del fuoco che spira della boca e degli ochi e
dello naso del cavaliere e del cavallo. E’ la notte che si addice al
peccato: la tenebra materiale corrisponde ora a quella tenebra che in vita rese
cieca la ragione, quando la lussuria consumò la sua malaugurata vittoria. Anche
per Francesca, nell’Inferno di Dante, c’è la notte, il loco d’ogne luce muto,
il buio senza tempo e senza fine del mondo sotterraneo. Se la luce è vita ed è
salvezza, non può esserci la luce per i maledetti da Dio.
Alla
luce piena del giorno avveniva invece, nella visione di Andrea Cappellano,
l’incontro del cavaliere con il corteo guidato dal dio Amore. Lì evidentemente
la passione amorosa non implicava in alcun modo l’idea di peccato; e questo non
solo perché, come s’è visto, ad essere punita era piuttosto la castità, ma
anche perché quell’oltretomba era associato ad un paesaggio terreno rischiarato
dal sole, la visione non comportava il passaggio ad una dimensione allucinata
ed angosciante, ma si compiva in un ambiente naturale i cui elementi, per
quanto dolorosi, sono riconoscibili e familiari, appartengono alla quotidianità
(il sole cocente, la polvere, i cavalli zoppi e macilenti, le spine) (19). E
ciò sembra appropriato ad una concezione laica che si serve sì, in ossequio
alle idee dominanti, di una visione ultraterrena, ma sostanzialmente tratta in
termini naturali e terreni una questione naturale e terrena come l’amore fra
l’uomo e la donna.
IV. Alla luce piena del
giorno avviene anche la visione di cui narra Boccaccio nella novella di
Nastagio degli Onesti (20). E questo sarebbe già il segno, se non ci fossero
anche altri e ben vistosi elementi, di una mentalità non più ossessionata dalla
paura del peccato e della dannazione eterna.
Si
tratta, come è noto, di una visione che presenta tali somiglianze con quella
del carbonaio di Niversa da far pensare che la fonte sia comune o che Boccaccio
conoscesse Passavanti (21).
In
breve. Nastagio, non corrisposto nel suo amore per una de’ Traversari,
si ritira da Ravenna a Chiassi. Qui un giorno, quasi all’entrata di maggio,
essendo uno bellissimo tempo, mentre immerso nei suoi pensieri si inoltra
nella pineta, si imbatte, verso il mezzo dì, in una bellissima giovane
ignuda, scapigliata e tutta graffiata dalle frasche, che corre piangendo e
gridando, inseguita da due grandi e fieri mastini e da un cavalier
bruno, forte nel viso crucciato, con uno stocco in mano. Nastagio vorrebbe
aiutare la fanciulla, ma il cavaliere - che si presenta come Guido degli
Anastagi, nobile ravennate, morto quando Nastagio era fanciullo - lo invita a
non impicciarsi e gli spiega che ciò che vede è voluto dalla giustizia di Dio:
lui infatti, innamorato non corrisposto di quella fanciulla, si era ucciso
disperato; lei, tutt’altro che pentita della sua crudele ostinazione, era morta
poco dopo; entrambi sono dannati all’inferno (22) e la pena consiste appunto in
questa caccia, per cui lui la insegue, la raggiunge ogni venerdì a quell’ora in
quel punto, la trafigge con lo stesso stocco con cui si era ucciso, la squarta,
estrae il cuore e lo dà da mangiare ai cani; quindi lei si rialza come se
niente fosse, ricomincia la fuga e ricomincia la caccia. E così avviene.
Nastagio, dopo essere stato per un po’ tra pietoso e pauroso, capisce di
poter sfruttare l’informazione a proprio vantaggio. Per il venerdì successivo
fa apparecchiare proprio in quel punto un grande banchetto, cui invita parenti,
amici e tutta la famiglia Traversari. La bella da lui amata, quindi, assiste
alla scena raccapricciante, ascolta la spiegazione del cavaliere e non può non
riconoscere che la stessa sorte della fanciulla dannata sarà riservata a lei,
se continuerà a rifiutare il suo amore a Nastagio. Pertanto nottetempo gli
manda una sua cameriera per fargli sapere che ella era presta di far tutto
ciò che fosse piacer di lui. Nastagio se ne rallegra, ma risponde che con
onor di lei voleva il suo piacere, e questo era sposandola per moglie. Lei
acconsente e la storia si conclude con il lieto fine del matrimonio cui fa
seguito una lunga vita felice (23).
E
dunque qui la caccia infernale ha una funzione esattamente opposta a quella che
aveva nell’exemplum di Passavanti. Là doveva insegnare che cedere alla
passione amorosa è un peccato degno, dopo la morte, delle pene più terribili;
in Boccaccio, al contrario, è la ritrosia in amore ad essere indicata come
degna del castigo divino, e la visione serve a persuadere le donne che è bene
accondiscendere alla richiesta d’amore (24). L’effetto parodistico è evidente (25),
come è evidente che tale effetto è stato ottenuto innestando, sul modello
cristiano della caccia tragica, elementi che provenivano da tutt’altra
tradizione, e precisamente da quella che fa capo al De amore di Andrea
Cappellano (26).
Qualche
osservazione basterà a dimostrarlo.
Anzitutto,
i protagonisti della novella si muovono in un mondo che richiama alla memoria,
col nome stesso delle famiglie dei Traversari e degli Anastagi, ambienti di
gioiosa e raffinata cortesia (27); e cortesi sono i modi di Nastagio, sia
perché ama una donna di condizione sociale superiore alla sua (troppo più
nobile che esso non era), come espressamente raccomandato da Andrea (28),
sia perché, per amore, conduce la più bella vita e la più magnifica che mai
si facesse, seguendo il precetto della liberalità, fondamentale per un
amante cortese (29).
Entrando
nel dettaglio, non solo l’ora meridiana (di cui s’è già detto), ma anche la
stagione primaverile e il paesaggio ameno della pineta (30), che fanno da
sfondo alla visione di Nastagio, ne indicano l’affinità con la visione del
cavaliere nel libro di Andrea (31); e il tutto, in Boccaccio, contribuisce a
mitigare l’orrore della scena. Al contrario, l’atmosfera cupa e tenebrosa,
propria della linea Elinando-Passavanti, intendeva senz’altro accentuare
quell’orrore. Quanto alla scena in sé, è vero che il cacciatore è altrettanto
spietato e violento (la caccia è altrettanto "tragica") in ambedue le
visioni, di Nastagio e del carbonaio di Niversa: ma mentre in Passavanti la
distanza dal quotidiano è volutamente marcata con l’insistenza sul
soprannaturale (si pensi a quel cavallo e quel cavaliere che spirano fuoco dagli
occhi, dal naso e dalla bocca) e sul sangue (cadendo in terra con molto
spargimento di sangue, la riprese per l’insanguinati capelli), in Boccaccio
il soprannaturale è limitato, per così dire, allo stretto necessario (la
rinascita della donna dopo lo squartamento), ed anche l’opera del cacciatore,
pur con i suoi particolari raccapriccianti, è tutto sommato riconducibile alla
quotidianità di un lavoro da macelleria (il coltello sembra maneggiato con una
certa professionalità, quando il cacciatore dice aprola per ischiena, e quel
cuor... con l’altre interiora insieme... le caccio di corpo e dolle mangiare a
questi cani ; e poi, di fatto, quella aprì nelle reni, e fuori trattone
il cuore e ogni altra cosa dattorno, a’ due mastini il gittò); del resto,
quel banchetto preparato da Nastagio con cura e raffinatezza (fece le tavole
mettere sotto i pini dintorno..., fatti mettere gli uomini e le donne a
tavola..., essendo adunque venuta l’ultima vivanda...) fa pensare ad una
cortese brigata che si accinge ad assistere ad un piacevole spettacolo,
ancorché a tinte forti, invece che ad una terribile visione: tutt’altra
atmosfera rispetto a quella, paurosa ed angosciante, che incombe sul conte e il
carbonaio di Niversa in attesa dell’evento.
Se
ne può concludere, insomma, che Boccaccio tratta quel materiale medievale con
una sensibilità che non è più medievale, non solo perché rovescia beffardamente
le funzione di un exemplum edificante, ma anche perché, coi modi stessi
della narrazione, dimostra di non avvertire, se non pretestuosamente, la
presenza del divino (e del diabolico) nelle vicende terrene. Così come, circa
un secolo e mezzo prima, non l’avvertiva Andrea Cappellano, il quale,
altrettanto pretestuosamente, per trattare d’amore si era servito del
soprannaturale.
Nel
tramonto del Medioevo, è dunque la voce di Andrea che torna a farsi sentire: la
sua idea dell’amore che, fieramente osteggiata dalla Chiesa, per sopravvivere
aveva dovuto rinunciare alla sensualità e ricoprirsi di vesti cristiane, torna
con la sicurezza sorridente (e irridente) di un autore, Boccaccio, che di certo
non si sente trattenuto da scrupoli e obiezioni di tipo religioso.
Ma
l’etica cortese, cui Andrea aveva dato sistemazione nel suo trattato, viene
rivisitata e corretta alla luce dell’etica borghese, ormai trionfante nella
società cui Boccaccio appartiene. Si pensi, ad esempio, a una certa aura di
negatività che nella novella, a dispetto del precetto cortese della liberalità,
si riverbera da quello spendere smisuratamente di Nastagio (talché i
suoi parenti temono per il patrimonio); o anche, ed è elemento davvero vistoso,
alla scelta finale del matrimonio ‘onorevole’, che contraddice seccamente
quella precettistica. Bisognerà appunto considerare che Boccaccio, per quanto
guardi con sincera nostalgia alle idealità di un mondo ormai lontano, è pur
sempre l’interprete di una società (borghese) in cui si sono imposti altri valori,
si rivolge ad un pubblico per il quale il lieto fine non può essere dissociato
dall’amministrazione oculata del patrimonio e dal rispetto delle convenienze
sociali (32).
Si
potrebbe dire che etica cortese ed etica borghese si sono alleate, individuando
nell’etica cristiana il comune nemico. In altre parole, riconoscere il tono
parodistico della novella di Nastagio non vuol dire negare a Boccaccio l’intenzione
consapevole (del resto evidente in tanti luoghi del Decamerone) di
sottrarre l’amore al regno del peccato per collocarlo in quello dei bisogni
naturali dell’uomo. Passavanti è lontano, ma è lontano anche Dante. L’amore
terreno non è più esecrato come causa di dannazione, ma nemmeno è liberato dal
peso della sua materialità perché possa indirizzarsi al cielo: è semplicemente
accettato come una forza incomprimibile della natura, che determina, al pari e
più di altre, i comportamenti dell’uomo.
E
naturalmente non desta meraviglia che a tale mutamento di prospettiva dia voce
un autore così rappresentativo di quell’età di transizione in cui comincia ad
affermarsi una nuova concezione dell’uomo e del mondo. Non sarà un caso se alla
fine del Quattrocento, Botticelli - che pure opera in un ambiente di alta
spiritualità quale quello neo-platonico della corte di Lorenzo de’ Medici -
illustrerà proprio la novella di Nastagio in quattro tavolette destinate a
decorare la cassa da corredo per una sposa (33);



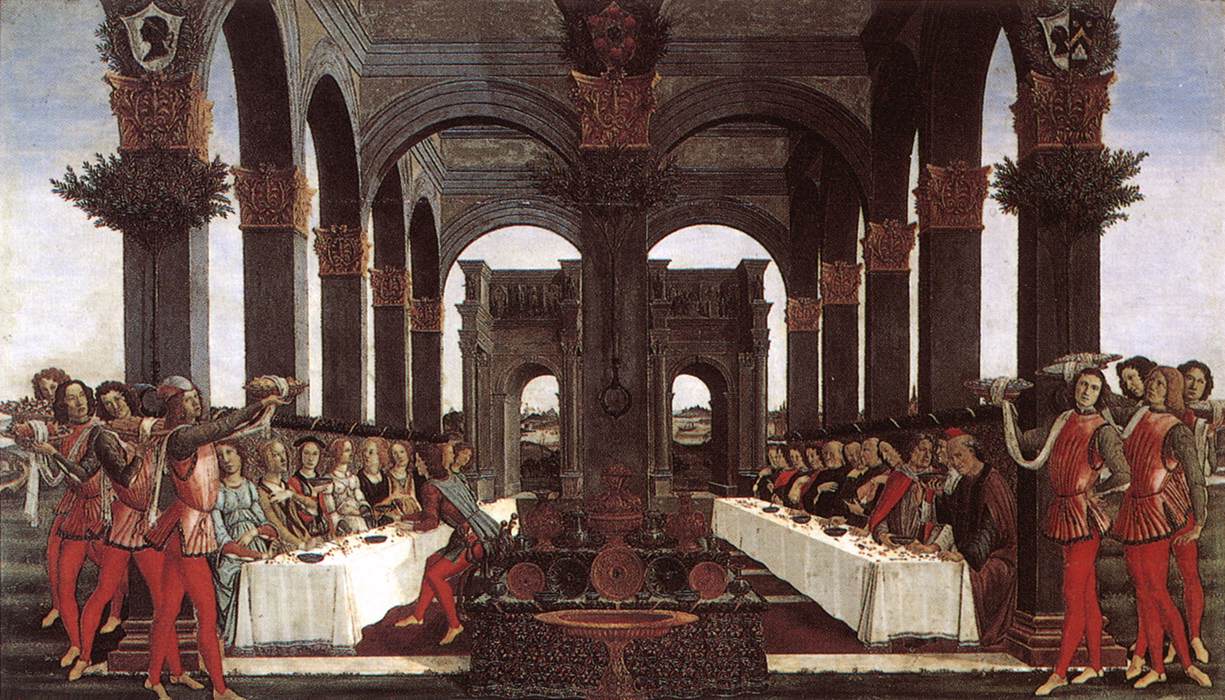
e se in pieno Rinascimento, Ariosto, visibilmente riallacciandosi a quella tradizione che risaliva ad Andrea Cappellano, immaginerà punite all’inferno, ancora una volta, le donne che non vollero amare ed essere amate (34).



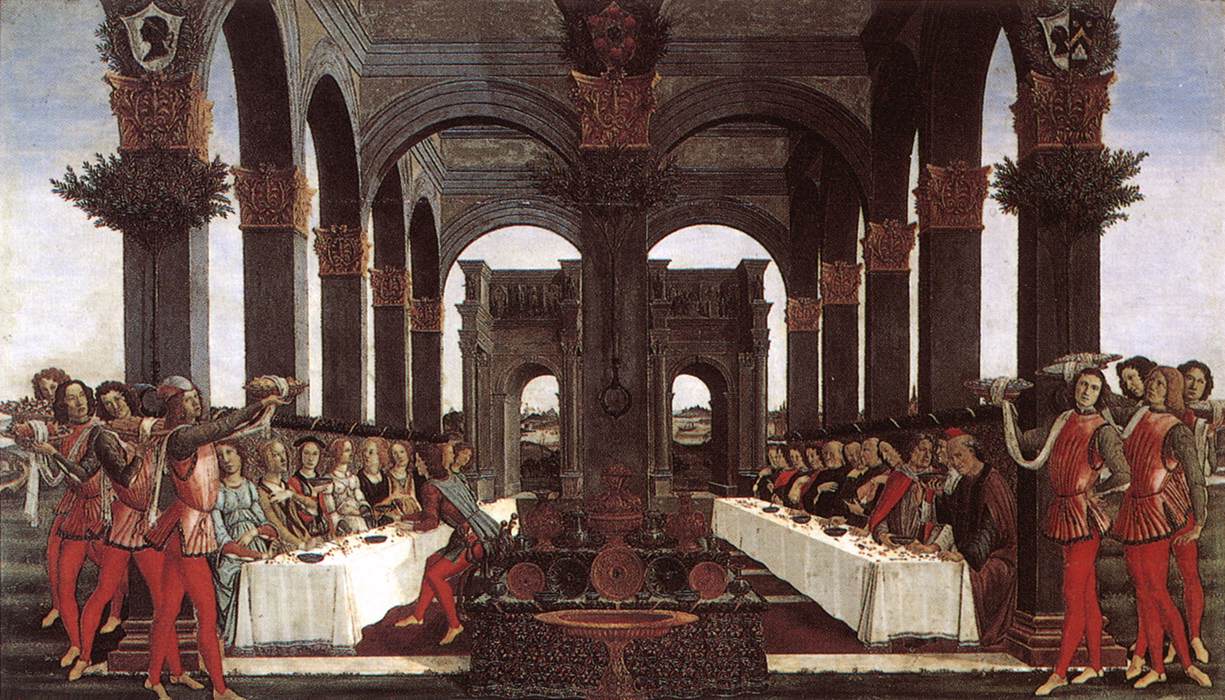
e se in pieno Rinascimento, Ariosto, visibilmente riallacciandosi a quella tradizione che risaliva ad Andrea Cappellano, immaginerà punite all’inferno, ancora una volta, le donne che non vollero amare ed essere amate (34).
Marcello
TARTAGLIA
Articolo
pubblicato su Studi di estetica, 17
III serie, 1998,
a. XXVI
NOTE
2)
Si tratta di una concezione sulle cui origini (latine, germaniche, celtiche,
arabe) molto si è discusso, ma che indubbiamente - quali che siano gli stimoli
culturali in essa confluiti: si pensi, soprattutto, all’Ars amandi di
Ovidio - si pone come radicalmente nuova, sia rispetto alla tradizione classica
(che concepisce l’amore come sensuale, fonte di gioia e dolore, ma sempre, in
definitiva, come una malattia che fa perdere il senno), sia, come diremo,
rispetto alla concezione cristiana. Nuova è l’idealizzazione della donna, cui
l’uomo si sottomette con umiltà e fedeltà di ‘vassallo’, e nuova è l’idea
dell’amore come un sentimento nobile e nobilitante, proprio soltanto di chi ha
costumi, ed animo, ‘cortesi’ . Ed è una novità che impronterà di sé la cultura
occidentale fino ai giorni nostri. Della vastissima bibliografia in merito,
mi limiterò a ricordare gli studi più significativi: M. FAURIEL, Histoire de
la poésie provençale, Parigi 1846; E. WECHSSLER, Frauendienst und
Vassalität, in "Zeitschrift für französiche Sprache und
Literature", XXIV, Iena 1902; Das Kulturproblem des Minnesangs,
Halle 1909; J. ANGLADE, Les troubadours, leurs vies, leurs œuvres, leur
influence, Parigi 1908; A. JEANROY, La poésie lirique des Troubadours,
Parigi 1934; C. S. LEWIS, The Allegory of Love, Oxford, 1936 (tr. it., L’allegoria
d’amore, Torino 1969); A.J. DENOMY C. S. B., An Inquiry into the Origins
of Courtly Love, in "Mediaeval Studies", VI, Londra 1944; Fin’Amors:
the Pure Love of the Troubadours, its Amorality, and Possible Source,
ibid., VII, 1945; R. NELLI, L’érotique des troubadours, Parigi 1974
[Tolosa 1963]; R. BEZZOLA, Les origines et la formation de la littérature
courtoise en Occident (500-1200), Parigi 1944-63; M. LAZAR, Amour
courtois et "fin’amors" dans la littérature du XII siècle, Parigi
1964; C. CAMPROUX, Le Joy d’Amor des Troubadours, Montpellier 1965; A.
VISCARDI, Tradizione latina e origini romanze, in Le Origini,
Milano 1966 [1939]; I. MARGONI, Fin’amors, mezura e cortesia. Saggio sulla
lirica provenzale del XII sec., Milano 1965; E. KÖHLER, Sociologia della
fin’amors. Saggi trobadorici, Padova 1976; H. REY-FLAUD, La nevrose
courtoise, Parigi 1983 (tr. it., Parma, 1991). Per altre indicazioni
bibliografiche, rimando allo studio di R. Nelli sopra citato (tomo II, pp.
383-397), nonché alla bibliografia ragionata, a cura di A. M. Finoli, in
appendice a M. VISCARDI, Le letterature d’oc e d’oil, Firenze-Milano
1967 (pp. 429-452).
Nessun commento:
Posta un commento